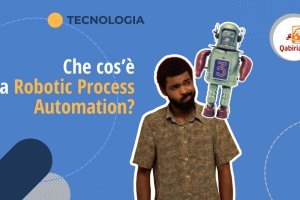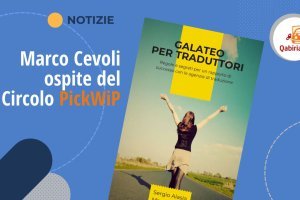Indice
Chi sono e cosa fanno gli onomaturghi
Gli onomaturghi sono gli inventori di neologismi (dall’unione delle parole greche néos, “nuovo”, e lógos, “parola, espressione”). Ma da dove nasce l’esigenza di creare parole nuove?
Per rispondere, dobbiamo fare un passo indietro, negli anni ’60 del secolo scorso, quando i ricercatori Edward Sapir e Benjamin Whorf turbarono il mondo della linguistica ipotizzando che il nostro linguaggio determinasse il modo in cui vediamo il mondo. Pertanto, abbracciando questa teoria, si può affermare che l’essere umano ha la responsabilità di inventare nuove parole per immaginare un mondo migliore.
Proprio per questo motivo abbiamo deciso di passare in rassegna alcuni inventori di parole che hanno lasciato un segno indelebile nella società. Ovviamente, è impossibile includere tutti gli inventori di neologismi in un unico articolo: cercheremo quindi di accogliere alcuni dei più influenti e originali.
Quante parole ci sono nelle lingue più usate
Secondo alcune fonti l’inglese è la lingua che ha il vocabolario più vasto, con 490.000 parole di linguaggio corrente e 300.000 di linguaggio tecnico. Ciononostante, le lingue sono in continua evoluzione, ed è pertanto molto difficile affermare con esattezza quanti vocaboli contengono.
Le parole della lingua italiana non sono mai state censite, quindi la cifra esatta è difficilmente quantificabile. Il sito Treccani prova a farne una stima: si va dai 210.000 lemmi del Grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia ai 260.000 del Grande dizionario italiano dell'uso di Tullio De Mauro.
Una volta declinati o coniugati, i vari lessemi generano più di due milioni di “parole dicibili e scrivibili” in italiano. Tutto questo tenendo conto che ci sono 50.000 lessemi con più di un’accezione (“penna” è un oggetto per scrivere, ma è anche una piuma di uccello), 27.000 con più di due accezioni e ben 9000 lessemi con più di cinque accezioni.
Ma quante parole del lessico comune vengono realmente utilizzate dagli italiani? Secondo i più importanti linguisti italiani, individui con un’istruzione medio-alta utilizzano fino a 47.000 vocaboli, mentre il vocabolario di base della nostra lingua si attesta su 6500 parole, con le quali gli italiani coprono il 98% dei loro discorsi.
Infine, esiste una netta differenza tra le parole di nuovo conio, più precisamente indicate come “neologismi lessicali”, e i neologismi costituiti da più parole che finiscono per combinarsi in un sintagma nominale stabile denominato “neologismo sintattico”. Per esempio, al primo insieme appartiene la parola “petaloso”, mentre al secondo l’espressione cristallizzata “laurea breve”. In questo articolo, ci concentreremo principalmente sui neologismi lessicali.
Gianni Brera
Visto che in Qabiria utilizziamo spesso la metafora del calcio, iniziamo questa rassegna da Gianni Brera, giornalista e scrittore sportivo del secolo scorso, a cui si deve probabilmente la nascita di un linguaggio sportivo vero e proprio.
Alcune delle parole inventate da Brera sono entrate di fatto nel lessico comune: contropiede (un tempo si diceva contrattacco, l’allenatore Arrigo Sacchi invece direbbe ripartenza), libero (difensore esente da compiti di marcatura fissi), centrocampista (il calciatore che agisce nell’area del centrocampo), incornata (per indicare un colpo di testa verso la porta avversaria), palla-gol (occasione chiara per fare gol) e pretattica (dichiarazioni rilasciate dagli allenatori alla vigilia di un incontro).
Brera può essere considerato il precursore dell’onomaturgia del mondo dello sport, ma dopo di lui sono stati coniati tanti altri termini. Basti pensare ai più recenti tiraggiro (“tiro a giro” fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare), sarrismo (la concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva), cassanata (gesto, comportamento, trovata, tipici del calciatore Antonio Cassano, celebre per atteggiamenti poco nella norma), ecc.
Dante Alighieri
Tra gli inventori di parole più influenti della nostra cultura c’è sicuramente Dante.
Espressioni come “galeotto fu…” e “non ragioniam di lor ma guarda e passa” sono entrate a far parte del lessico comune e sono tratte dalla Commedia.
Quando parliamo dell’Italia diciamo “Il bel Paese”, definizione utilizzata per la prima volta proprio da Dante, al v. 80 del canto XXXIII, dove definisce Pisa “vituperio delle genti del bel paese”, a dimostrazione della grande rivalità fra Firenze e la città toscana.
“Senza infamia e senza lode”: anche questo modo di dire è una creazione dell’estro di Dante, in riferimento agli ignavi, tanto odiati dall’autore fiorentino, ma utilizzata oggi con una connotazione meno estrema.
Altro famoso termine coniato da Dante è bolgia, usato per indicare ciascuna delle dieci fosse in cui si divide l’ottavo cerchio dell’Inferno. Oltre a diffondersi col significato relativo alla struttura dell’Inferno, la parola viene usata per indicare un luogo di peccato, di sofferenza e assume anche il significato odierno di luogo pieno di gente, confusione, disordine, ma anche affollamento, calca.
Nel canto II dell’Inferno, Beatrice pronuncia l’espressione “Non mi tange” (v. 93), a indicare qualcosa che non le interessa, che non la sfiora neppure. La donna l’adotta per spiegare a Virgilio di non temere affatto il regno di Lucifero essendo lei una creatura divina e quindi imperturbabile di fronte alla malvagità del diavolo. Oggigiorno siamo imperturbabili di fronte a molte più cose, a giudicare dalla diffusione dell’espressione...
Gabriele D’Annunzio
Oltre che scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, Gabriele D’Annunzio è stato uno straordinario onomaturgo, sicuramente uno dei più influenti della lingua italiana.
Restando in ambito sportivo, a D’Annunzio dobbiamo l’invenzione della parola scudetto, ovvero il triangolino di tessuto tricolore che si applica alle maglie della squadra di calcio vincitrice del Campionato. Il Poeta chiamò scudetto proprio il primo triangolino cucito (dietro sua indicazione) sulla divisa indossata dalla nazionale italiana in una partita di calcio organizzata durante l’occupazione di Fiume (il 7 febbraio del 1920).
Gabriele D’Annunzio era anche un abile aviatore e, come fece in tutti gli altri settori in cui operò, anche in questo dimostrò il suo estro, ideando la parola velivolo, dal latino velivolus, “che va e par volare con le vele”. Nel 1910, durante una conferenza sul Dominio dei cieli, D’Annunzio spiegò perché creò la parola velivolo:
“La parola è leggera, fluida, rapida; non imbroglia la lingua e non allega i denti; di facile pronunzia, avendo una certa somiglianza fonica col comune veicolo, può essere adottata dai colti e dagli incolti”.
Un altro termine tecnico coniato da D’Annunzio è “fusoliera”, per indicare la parte dell’aereo di forma allungata nel senso del moto.
Nel 1925, durante una visita al Caffè Mulassano a Torino, il Poeta inventò la parola “tramezzino”, subito dopo aver assaggiato un particolare tipo di panino farcito con burro e acciughe. “Ci vorrebbe un altro di quei golosi tramezzini…”, avrebbe esclamato. Da allora, la pietanza prese questo nome. Probabilmente, il neologismo si oppone alla parola inglese sandwich e trova origine nel linguaggio architettonico: tramezzo significa infatti “elemento posto in mezzo ad altri elementi”.
Curiosità: fu proprio D’Annunzio a coniare i nomi propri di alcuni personaggi fantastici: Maciste, l’eroe forzuto, e Cabiria, la sacerdotessa, per il film omonimo di Giovanni Pastrone, da cui abbiamo tratto ispirazione per il nome della nostra società.
Giacomo Leopardi
Il poeta di Recanati è il padre di nuove parole, non così diffuse all’epoca perché percepite di tono elevato. Tra queste troviamo erompere, incombere, improbo, fratricida. Come capita spesso alle personalità più geniali, a dispetto della riluttanza iniziale, questi neologismi sono entrati a far parte del lessico comune solo dopo molti anni di scetticismo.
Beppe Fenoglio
La creatività linguistica, in particolare lessicale, e il gusto del neologismo costituiscono le caratteristiche fondamentali della prosa di Beppe Fenoglio, soprattutto del suo capolavoro, Il Partigiano Johnny.
Fenoglio attinge da numerose fonti linguistiche per arricchire la propria prosa. L’italiano è per lui una lingua seconda, appresa sui banchi di scuola, e una lingua che non corrisponde a quella della vita quotidiana. Inoltre, è la lingua del regime, e la rivolta di Fenoglio si manifesta anche attraverso la contaminazione dell’italiano con altri sistemi linguistici, su tutti la lingua inglese.
Oltre a utilizzare direttamente parole inglesi, Fenoglio impiega veri e propri calchi lessicali, con il loro adattamento alla morfologia e alla fonologia dell’italiano. Per esempio to affect (colpire) diventa affettare (“il normale passo di strada di Johnny affettava notevolmente i suoi polmoni e milza”), to trim (tagliare) diventa trimmersi (“prese a trimmersi col fuoco della sigaretta quei peli sulle braccia”).
Inoltre, l’abilità neologica di Fenoglio consiste nell’originalità dei procedimenti di formazione delle parole di cui si serve per creare il proprio lessico. Per quanto riguarda l’affissazione, Fenoglio costruisce parole nuove e originali con prefissi negativi (in-, a-, s-, dis-, ma anche un-) e suffissi in uso (–ico e –oso). Ecco qualche esempio:
- in- + aggettivo: incollettivo, inrancorosa, insolidale, ecc.
- in- + participio passato: incollaudati, inlavata, inmascherata, inprotetti;
- in- + participio presente: inaiutante, incapente, infrenante, intacente;
- in- + -bile: inarrendibili, indisquisibile, inscampabile;
- -ico: “l’antagonismo era acmico (da acme) sotto il fiero sole”; “nella sua irriservata, martirica (da martire), silente-aggressiva ammirazione per l’America”;
- -oso: (esperienza) brividosa; (posto) correntoso; (erta) motosa; (smaniare) sudoroso.
Questi sono solo alcuni esempi di neologismi fenogliani. Il Partigiano Johnny ne è stracolmo e la tendenza a creare nuove parole lascia intendere la necessità dell’autore di allontanarsi dalla lingua del regime e di cercare il rinnovamento in altri codici linguistici.
William Shakespeare
L’immortalità di William Shakespeare non è dovuta soltanto alle sue opere, ma anche alle circa 2000 parole ed espressioni inventate, molte delle quali utilizzate ancora oggi e presenti nell’Oxford English Dictionary. Uno su tutti: manager. Questo termine è ormai utilizzato in tutto il mondo ed è stato inventato proprio dallo scrittore di Romeo e Giulietta.
Una delle tecniche più adottate da Shakespeare per la creazione di nuove parole è l’aggiunta di un suffisso a una parola già esistente per derivarne il significato. Ecco allora la comparsa dell’aggettivo gloomy (buio, scuro) tratto dal verbo to gloom, o di bloody (sanguinoso, violento) da blood (sangue).
What’s done is done (quel che è fatto è fatto): chi non ha mai utilizzato questa espressione? È comparsa per la prima volta in Macbeth nel lontano 1611. E ancora: all’s well that ends well (tutto è bene quel che finisce bene), espressione che proviene dall’omonima opera All’s well that ends well, scritta tra il 1604 e il 1605. Insomma, la straordinaria creatività di Shakespeare ha oltrepassato anche i confini nazionali, influenzando il modo di parlare (e di vedere il mondo) anche di noi italiani.
Cortázar e Il gioco del mondo
Per molti autori, inventare diventa un esperimento, un gioco per uscire fuori dai margini e rivoluzionare la propria scrittura. Nella sua opera più celebre, Il gioco del mondo, lo scrittore argentino Julio Cortázar abbandona il linguaggio convenzionale per entrare nella parte più emotiva della mente umana.
Ci riesce tramite giochi di parole, cambi di punteggiatura e uso di neologismi. Vuole inventare, costruire un mondo nuovo. Cortázar infatti non è solo un onomaturgo, ma addirittura l’ideatore di un nuovo linguaggio, il gliglico, che il protagonista, Horacio Oliveira, condivide con Lucia, “la Maga”, nei momenti di maggiore intimità. Nel libro in questione, c’è un intero capitolo (il n. 68) scritto in questa lingua inventata, attraverso la quale l’autore intende parlare di erotismo, in un modo che il linguaggio convenzionale non riesce a fare. Ecco un breve estratto della traduzione di Flaviarosa Nicoletti Rossigni:
“Appena lui le amalava il noema, a lei sopraggiungeva la clamise e cadevano in idromorrie, in selvaggi ambani, in sossali esasperanti. Ogni volta che lui cercava di lequire le incopeluse, si avviluppava in un grimado lamentoso e doveva invulsinarsi di fronte al novelo, sentendo in qual modo a poco a poco le arniglie si specunnavano, peltronandosi, redduplinandosi, fino a restare come il trimalciato di ergomanina al quale son state lasciate cadere delle fillule di cariconcia”.
In Italia esempi simili non mancano, su tutti i primi versi del Lonfo di Fosco Maraini, dalla raccolta Gnòsi delle Fànfole:
“Il lonfo non vaterca né gluisce e molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego a bisce bisce sdilenca un poco, e gnagio s’archipatta”.
James Joyce
Lo scrittore dell’Ulisse è famoso per il suo flusso di coscienza, ma è stato anche un prolifico inventore di neologismi. Aveva la necessità di esprimere sensazioni e concetti per cui la lingua non prevedeva lemmi adeguati. E così, per dare forma al suo linguaggio, ha dato vita a parole polisemiche e neologismi di ogni tipo. Quark, crasi di question mark nell’Ulisse, venne utilizzata dal fisico Gell-Mann per dare il nome alle particelle subatomiche. Sunnywinking leaves, sempre nell’Ulisse, indica le foglie che si muovono al vento come delle palpebre, traducibile (azzardando) con un foglie sbattipalpebralsole.
Mrkgnao è l’onomatopea del verso del gatto e tattarrattat è quella del bussare alla porta, che pare sia anche il palindromo più lungo della letteratura inglese. Insomma, un linguaggio onirico funzionale alle esigenze dell’autore e del lettore.
Conclusione
Come abbiamo visto, la necessità di creare parole nuove può derivare dall’esigenza di descrivere nuove realtà o concetti, può essere un esercizio di stile, ma può anche rispondere alla voglia di ribellarsi alla lingua normalizzata e a tutto ciò che essa rappresenta. A prescindere da quale sia il nostro punto di vista riguardo agli onomaturghi e alla creazione di nuovi lemmi, una cosa è certa: la lingua la fanno i suoi parlanti, perché è qualcosa di vivo e difficilmente controllabile.
In Qabiria non inventiamo parole (non ancora), ma se hai bisogno di una mano per rendere più creativi i tuoi scritti, contattaci senza impegno!