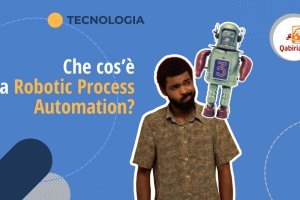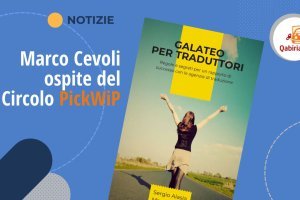La parola neologismo è costruita sull’aggettivo greco néos (“nuovo”) e sul sostantivo lógos (“parola, espressione”). Si tratta di parole nuove che, come una specie di terremoto, all’improvviso scuotono il mondo dei dizionari, facendo storcere il naso ai linguisti più puristi.
La forma francese néologisme è documentata per la prima volta nel 1734, all’interno de L’Encyclopédie, ed è definita così:
“la predilezione di alcune persone all’uso di espressioni nuove e diverse da quelle consentite dall’uso. […] Il neologismo non consiste solo nell’introduzione nel linguaggio di nuove parole inutili, ma anche di giri di parole, e nell’accostamento azzardato di termini e nella stranezza delle immagini evocate dal neologismo”.
Perché nascono i neologismi
A quanto pare, quindi, i neologismi non erano (e non sono) visti di buon occhio, apparendo come una specie di trasgressione, un’attività insignificante.
Eppure, in un determinato momento, la parola neologismo è stata essa stessa un neologismo, e la ragione è evidente: gli esseri umani hanno bisogno di parole nuove per descrivere realtà nuove. Il neologismo apre le porte della lingua (e della società) sul mondo che verrà. In primo luogo, quindi, il neologismo risponde all’esigenza di descrivere fenomeni e cambiamenti sociali e culturali, di dare un nome a una nuova tecnologia o a un nuovo concetto.
Pierre Larousse considerava il suo dizionario come un dagherrotipo capace di immortalare il linguaggio e la direzione che stava prendendo la società. Oltre alla sua capacità descrittiva, infatti, i neologismi sono la fotografia della vivacità di una lingua e dei suoi parlanti.
Ogni anno si attende l’uscita delle nuove edizioni dei più autorevoli vocabolari, proprio per capire dove stiano andando la nostra lingua e la società.
Per citare solo un esempio, nell’edizione 2022 del vocabolario monolingue Devoto-Oli compaiono oltre 500 parole nuove, a dimostrazione di quanto le lingue siano dinamiche e creative.
In che modo nascono le parole
In genere si parla di forestierismi (o prestiti) nel caso di parole che provengono da lingue straniere, e di neologismi per quelle derivate da altri termini già presenti in una data lingua. Eppure, molto spesso i prestiti vengono inclusi tra i neologismi.
I neologismi sono detti “lessicali”, quando comportano l'inclusione nel vocabolario di una vera e propria parola nuova. Tra questi neologismi, sono detti “combinatori” quelli il cui processo creativo combina elementi della lingua secondo le regole tipiche di formazione delle parole (affissazione, composizione). Sono invece detti “semantici” i neologismi che consistono nell'attribuzione di un nuovo significato a un termine già in uso (come per l’italiano navigare su internet o la chiocciola per il simbolo \@). Si dicono modismi i neologismi di durata passeggera.
I neologismi sono talvolta creati mediante la fusione di parole già esistenti (neologismo sincratico) o aggiungendo nuovi suffissi e prefissi (la parola lottizzare, per esempio, è stata creata da lotto + il suffisso -izzare).
Un’altra possibilità per creare neologismi è il cosiddetto tamponamento di parole. Sotto questo termine, vengono incluse l’acronimia, che consiste nel tagliare e nel fondere tra loro le parole: un esempio è eliporto, da _elicottero _e aeroporto, e le parole macedonia, che derivano da più unità: automobilistico+ ferroviario+ tranviario = autoferrotranviario.
I neologismi possono nascere traducendo una parola da una lingua straniera. Per esempio, la parola compersione è la traduzione della parola inglese compersion, che indica il contrario della gelosia, ovvero il piacere che una persona prova quando il proprio partner è con qualcun altro.
Una parola nuova può nascere anche adattando una parola straniera. Per esempio, la parola adultescente (persona adulta che si comporta con modi giovanili) è un adattamento dall’inglese adultescent, ricavato da adult e adolescent.
Anche la cosiddetta volgarizzazione di un marchio aziendale è un fenomeno in grado di generare neologismi. Quando si parla di uno scottex, non ci si riferisce necessariamente a un pezzo di carta da cucina di quella marca, perché la parola indica ormai, in maniera generica, qualsiasi tipo di carta da cucina. In linguistica queste parole si chiamano “eponimi”, ovvero nomi generici che derivano dal nome di una persona. Per esempio Disneyland o torta Sacher sono eponimi, in quanto derivano dai nomi di due persone: rispettivamente Walt Disney e Franz Sacher.
I neologismi sono molto diffusi nei settori tecnici e tecnologici. In particolare, vengono coniati con frequenza nuovi termini per dare un nome alle invenzioni associate alla rivoluzione informatica che stiamo vivendo da oltre trent’anni. Basti pensare all’irruzione nella nostra lingua di parole come blog, e-mail, craccare, chattare, hacker, spam, bug, patch, loggare, avatar, plug-in, pop-up, taggare, bannare, linkare, e chi più ne ha più ne metta.
Oltre al settore tecnologico, anche nel marketing si assiste all’invenzione costante di parole, più precisamente tramite il fenomeno del naming, l’attività che consiste nella scelta del nome più adatto a una marca, un prodotto/servizio in seguito a un’attenta analisi di questi ultimi, delle loro caratteristiche, del mercato di riferimento e del target a cui ci si rivolge. Il naming contribuisce così alla definizione di identità e posizionamento.
-
IKEA per esempio è un acronimo che combina le iniziali del suo fondatore, Ingvard Kamprad, con quelle dei luoghi della sua infanzia: la fattoria (Elmtaryd) e il nome del villaggio (Agunnaryd) dove è cresciuto.
-
Kodak non ha significato, e il suo fondatore, Eastman, disse di aver scelto il nome in quanto breve, facile da pronunciare e privo di significato. Però è interessante notare quanto il nome sia onomatopeico: ricorda infatti il suono di uno scatto fotografico.
-
Un altro esempio di successo è quello della Sony. La storica azienda tecnologia si è ispirata a due parole: sonus, suono in latino, ma anche a sonny, che in inglese stretto significa giovane brillante, Proprio per mettere in risalto la freschezza e la natura innovativa della marca.
Nota: un capitolo a parte meritano quegli autori, scrittori e giornalisti che coniano nuove parole ed espressioni grazie alla loro creatività e al loro estro. Gli abbiamo dedicato un articolo: “Gli onomaturghi, gli inventori di parole”.
Il caso “petaloso”
Era il febbraio del 2016 e in una scuola elementare di Copparo, un paesino in provincia di Ferrara, nella regione Emilia-Romagna, una maestra di scuola elementare, Margherita, assegna ai suoi studenti di terza elementare un compito di grammatica: associare due aggettivi a un nome. Uno degli studenti, Matteo, dirà che il fiore è profumato e petaloso, cioè pieno di petali.
La maestra, ovviamente, lo considera un errore (e lo è), dal momento che l’aggettivo petaloso non esiste in italiano. Ciononostante, propone una lezione sui neologismi e sul modo in cui entrano ufficialmente a far parte del vocabolario di una lingua. La storia però non si conclude in questo modo.
La maestra Margherita contatta l’Accademia della Crusca per ricevere una risposta al riguardo. La Crusca rispose, e da lì partì una catena di condivisioni e pubblicazioni sui social (e su varie testate) che diffusero la fama di questo neologismo o, quantomeno, della storia che lo precedeva. Tra le persone interessate alla questione ci fu anche Vera Gheno, sociolinguista che all’epoca gestiva l’account Twitter dell’Accademia della Crusca. Dopo aver condiviso la storia sul profilo Twitter della Crusca, gli utenti s’innamorarono di petaloso.
Le iscrizioni ai canali social della Crusca aumentarono vertiginosamente e l’hashtag #petaloso finì al primo posto dei trending topic. Insomma, si è trattato di un successo incredibile.
Il meccanismo di creazione che sta alla base della parola petaloso è corretto ed è, come abbiamo visto, uno dei tanti che utilizziamo per creare neologismi. Infatti, il suffisso -oso in italiano ha il significato di “pieno di”. Ad esempio, angoscioso deriva da angoscia + -oso/-osa e significa “pieno di angoscia”. Pertanto, tecnicamente il lemma era corretto, ma non poteva essere considerato come accettabile perché per essere registrata ufficialmente nel vocabolario di una lingua una parola deve rispondere a due condizioni fondamentali:
- ha bisogno di essere usata da un gran numero di persone;
- deve essere usata non solo per parlare della parola stessa, ma con il significato che si propone di diffondere; petaloso cioè doveva essere usato per esprimere il concetto di “pieno di petali”.
Al momento, l’aggettivo, pur considerato come “ben formato” dall’Accademia della Crusca, non è (ancora) entrato nei vocabolari. In ogni caso, come afferma la stessa Vera Gheno, il fenomeno “petaloso” ci lascia due insegnamenti fondamentali:
- i neologismi, come tutte le novità, scatenano la battaglia tra oppositori e sostenitori;
- le fake news sono sempre in agguato. Un noto politico italiano, infatti, per questioni di marketing, in riferimento all’Expo 2016, a Milano, parlò di progetti “petalosi”. Raccontò la storia del piccolo Matteo e concluse che la Crusca aveva inserito la parola nel vocabolario italiano. Doppiamente falso: la parola non era stata inserita in alcun vocabolario (né lo è stata adesso), e soprattutto, l'inserimento di parole nuove nel vocabolario non spetta certo alla Crusca.
Conclusione
In conclusione, se le parole sono l’unità fondamentale di una lingua, i neologismi possono essere considerati il mattone con cui i parlanti cercano di descrivere nuove realtà e concetti, senza soppiantare parole esistenti, ma riempiendo un vuoto semantico, o semplicemente per dare forma alla propria creatività.
I neologismi, inoltre, scatenano spesso accese discussioni sulla loro correttezza grammaticale o sulla necessità di esistenza perché, proprio come tutte le novità, tendono a dividere le comunità che li creano.
In Qabiria non inventiamo parole (non ancora), ma ci piace giocare con la lingua: chiamaci se ti serve aiuto per scrivere o migliorare i tuoi testi!